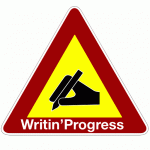Il punto di ritrovo crea un certo contrasto con la meta del viaggio che ci apprestiamo a fare, e come tale mi piace molto.
Il punto di ritrovo crea un certo contrasto con la meta del viaggio che ci apprestiamo a fare, e come tale mi piace molto.
Mentre osservo i resti alcolici dell’ennesima notte inconsapevole consumata allo Zoe, tiro fuori il foglietto con le istruzioni scaricate da internet che ci porteranno dritte dritte tra le braccia organiche di due fattorie comunitarie della campagna thailandese. Ricoprono un intero foglio A4 scritto fitto e mi chiedo se sia eccesso di zelo, questo, o una semplice indicazione di quanto remoti siano i due ecovillaggi.
Poi un motorino si ferma davanti a me. Rimetto il foglietto in tasca, indosso il casco che mi allungano e mi avvolgo la sciarpa attorno al viso per prepararmi alle montagne divorate dagli incendi.
Non sono un’ingenua: ho letto e respirato abbastanza in questi giorni per sapere che non sarà una sciarpina di cotone leggero (per altro clamorosamente bucato) a tenere lontane le microparticelle dai miei alveoli polmonari. È una resa veloce e ingloriosa per una persona che si è liberata dal fumo appena qualche mese fa, ma il richiamo del w-e che mi attende è troppo allettante per rinunciare a fumarmi una stecca di Marlboro sulla sella di un motorino sgangherato.
 Fuori Chiang Mai la situazione appare, se possibile, ancora più preoccupante. Il fumo invade le strade, le risaie e i fossati, penetra nella gola, si insinua tra le trame dei vestiti e le pieghe della pelle. Ma senza dubbio ha un certo fascino questo ambiente tropicale trasformato in paesaggio della pianura padana di inizio novembre. Sembra di essere sospesi. Direi che è il minimo, considerando la carenza di ossigeno!
Fuori Chiang Mai la situazione appare, se possibile, ancora più preoccupante. Il fumo invade le strade, le risaie e i fossati, penetra nella gola, si insinua tra le trame dei vestiti e le pieghe della pelle. Ma senza dubbio ha un certo fascino questo ambiente tropicale trasformato in paesaggio della pianura padana di inizio novembre. Sembra di essere sospesi. Direi che è il minimo, considerando la carenza di ossigeno!
Questo non vuole però essere un articolo sulla stagione degli incendi del nord Thailandia, quello l’ho già scritto, perciò acceleriamo i fotogrammi. Lanciamoci lungo le stradine arzigogolate che tagliano le risaie e i campi di mais, cerchiamo Il Grande Albero, Lo Stupa Dorato e La Porta Rossa, scivoliamo tra minuscoli villaggi che riportano indietro nel tempo e guardiamo lo scorrere muto e lento dei fiumiciattoli. Fino ad arrivare al cartello che stiamo cercando.
Dipinto su legno, come ogni cartello che si rispetti indica una svolta. Due strade sterrate di polvere rossa, due progetti comunitari, uno la costola dell’altro: a sinistra Pun Pun, a destra Panya Project. Il primo è esperimento ormai riuscito e funzionante, il secondo è più un work in progress. Figuriamoci se potevamo scegliere qualcosa di diverso da un work in progress.
Panya Project
 Ad accoglierci è Brian, americano di Atlanta dall’aspetto scompigliato e soddisfatto. Fa gli onori di casa, ci mostra l’edificio comune che lui stesso ha contribuito a costruire durante un corso di Natural building tenuto nella fattoria. Ci sono voluti appena due mesi a fare questa meraviglia di argilla e paglia, eppure é grande, apparentemente solida, colorata e bellissima. Al piano di sopra c’è spazio per libri, chitarre, tatami e una vista a largo raggio sull’orto comunitario e le montagne.
Ad accoglierci è Brian, americano di Atlanta dall’aspetto scompigliato e soddisfatto. Fa gli onori di casa, ci mostra l’edificio comune che lui stesso ha contribuito a costruire durante un corso di Natural building tenuto nella fattoria. Ci sono voluti appena due mesi a fare questa meraviglia di argilla e paglia, eppure é grande, apparentemente solida, colorata e bellissima. Al piano di sopra c’è spazio per libri, chitarre, tatami e una vista a largo raggio sull’orto comunitario e le montagne.
 Continuiamo il giro turistico della fattoria: ci sono alcune casette che spuntano qua e là, un carinissimo bagno comunitario su palafitta, le docce, che compensano con una vista sulla natura ciò che perdono in tecnologia. Conosciamo le galline e curiosiamo nella cucina all’aperto, dove finalmente leggo parole come “riciclo” e “risparmio” che un po’ mi fanno commuovere. Perché siamo in Thailandia e vi assicuro che questo è tutto tranne che scontato.
Continuiamo il giro turistico della fattoria: ci sono alcune casette che spuntano qua e là, un carinissimo bagno comunitario su palafitta, le docce, che compensano con una vista sulla natura ciò che perdono in tecnologia. Conosciamo le galline e curiosiamo nella cucina all’aperto, dove finalmente leggo parole come “riciclo” e “risparmio” che un po’ mi fanno commuovere. Perché siamo in Thailandia e vi assicuro che questo è tutto tranne che scontato.
Permacultura, compost toilet, spirito comunitario, immersione nella natura: al privilegio di scoprire questo bellissimo ecovillaggio si associa l’emozione mnemonica dei miei trascorsi comunitari in Australia, quando lavoravo la terra e deliziavo il mio corpo in vasche proiettate sulla foresta. Anche il principio che anima Panya è lo stesso di allora: trovare il modo di vivere facendo ciò che piace e aiuta a crescere, in armonia con gli altri e con la natura. Ponendo fine a quella corsa del topo che porta a vivere 30 anni di 40 ore settimanali a fare un lavoro che spesso e volentieri nemmeno ci piace.

Pun Pun
 Se Panya è un work in progress, Pun Pun è un ecovillaggio bello che collaudato, con i pro e i contro che questo comporta. I pro sono un piccolo barettino che serve il delizioso caffè delle tribù del nord e dove si possono acquistare manufatti locali e articoli di autoproduzione; orti ben equilibrati; deliziose case di fango dalle geometrie originali che si collocano nella natura rigogliosa in un rapporto di equilibrio armonioso; una cucina comunitaria ben organizzata con cibo vario e buono. I contro sono un apparente (e inevitabile) minore entusiasmo, un’accoglienza un po’ più freddina da parte degli abitanti e una maggiore scarsità di informazioni. Da una parte però li capisco: chi ha deciso di rifugiarsi qui è in cerca di quiete e silenzio e gli ospiti mordi e fuggi che fotografano a ogni angolo e sommergono di domande sono un po’ una mosca al naso.
Se Panya è un work in progress, Pun Pun è un ecovillaggio bello che collaudato, con i pro e i contro che questo comporta. I pro sono un piccolo barettino che serve il delizioso caffè delle tribù del nord e dove si possono acquistare manufatti locali e articoli di autoproduzione; orti ben equilibrati; deliziose case di fango dalle geometrie originali che si collocano nella natura rigogliosa in un rapporto di equilibrio armonioso; una cucina comunitaria ben organizzata con cibo vario e buono. I contro sono un apparente (e inevitabile) minore entusiasmo, un’accoglienza un po’ più freddina da parte degli abitanti e una maggiore scarsità di informazioni. Da una parte però li capisco: chi ha deciso di rifugiarsi qui è in cerca di quiete e silenzio e gli ospiti mordi e fuggi che fotografano a ogni angolo e sommergono di domande sono un po’ una mosca al naso.
 La natura qui è ancora più rigogliosa che a Panya, assomiglia a un bozzolo che preserva un mondo in apparenza incontaminato dal caos e dall’inquinamento esterno. Persino il fumo degli incendi sembra rispettoso di questo ambiente e se ne tiene alla larga. Ci gustiamo la pace lenta e coccolosa della terrazza del bar, sorseggiando caffè e spostandoci dall’amaca ai materassini thai e di nuovo all’amaca. Nessuno sembra avere fretta, tutti si muovono leggeri e silenziosi e noi cerchiamo di accordarci.
La natura qui è ancora più rigogliosa che a Panya, assomiglia a un bozzolo che preserva un mondo in apparenza incontaminato dal caos e dall’inquinamento esterno. Persino il fumo degli incendi sembra rispettoso di questo ambiente e se ne tiene alla larga. Ci gustiamo la pace lenta e coccolosa della terrazza del bar, sorseggiando caffè e spostandoci dall’amaca ai materassini thai e di nuovo all’amaca. Nessuno sembra avere fretta, tutti si muovono leggeri e silenziosi e noi cerchiamo di accordarci.
Ma non è solo l’atmosfera fuori dal tempo a rendere Pun Pun un piccolo gioiello, ma il ruolo preziosissimo che svolge come centro di conservazione di semi di frutta e verdura e scuola di bioedilizia. Sia qui che a Panya, infatti, è possibile partecipare a costi davvero accessibili a un corso per imparare a costruire una casa in materiali naturali. Che è un po’ il sogno di tutti: forgiare con le proprie mani un piccolo rifugio che non solo sia economico ed ecosostenibile, ma che rispecchi anche la nostra personalità e il nostro estro. Finalmente un modo carino per mettere le mani in pasta.
 Dopo avere fatto incetta di vita sostenibile, caldo e mosche, risaliamo paghi sul motorino, con quella sensazione mista di gioia per avere visto un posto speciale e di tristezza per apprestarci a salutarlo. Ma la tristezza dura poco, perché il w-e è appena iniziato. Ci attende un villaggio Karen (una delle tribù del nord della Thailandia), dove saremo ospiti di Lugher, della sua numerosa famiglia e degli spiriti delle montagne.
Dopo avere fatto incetta di vita sostenibile, caldo e mosche, risaliamo paghi sul motorino, con quella sensazione mista di gioia per avere visto un posto speciale e di tristezza per apprestarci a salutarlo. Ma la tristezza dura poco, perché il w-e è appena iniziato. Ci attende un villaggio Karen (una delle tribù del nord della Thailandia), dove saremo ospiti di Lugher, della sua numerosa famiglia e degli spiriti delle montagne.
Ma questa, come si dice, è un’altra storia.